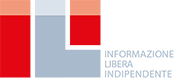TURISMO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO
Magia e stupore dell’arte in fondo al mare
Reperti, città e capolavori di altri millenni, musei di opere d’arte nate per vivere e respirare negli abissi, rendono il mare ambasciatore della cultura.
Donatella Zucca
In linea con le nuove tendenze di vita, quindi in sintonia con ambiente, natura e cultura, si fa sempre più strada il turismo archeologico subacqueo. Nell’ottica di valorizzare e tutelare tesori sommersi che raccontano di popoli, individui, fasi storiche e naturali lente e d’improvvisa violenza. Patrimoni di cui il Mediterraneo è ricco, in particolare l’Italia, portatori di un indiscusso valore culturale e di un turismo con grandi potenzialità ancora inespresse. Non a caso, questo tema è stato al centro della XXIII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico e spunto per la proposta al Consiglio d’Europa di un Itinerario Culturale Europeo, nell’ambito della Convenzione Unesco del Patrimonio subacqueo, che ha dato grande rilievo ai siti italiani.
Si chiama Blue Med e in Italia tocca la Calabria, negli anni Settanta sotto riflettori internazionali per il relitto di Porticello e i Bronzi di Riace ora nel museo archeologico di Reggio Calabria. Oggi di nuovo alla ribalta, con un percorso subacqueo e per snorkeling nella Marina Protetta di Capo Rizzuto, alla scoperta del relitto romano Punta Scifo D e le colonne di Capo Cimiti. Poi la Campania, col sito di Baia Sommersa nei Campi Flegrei e il Parco di Gaiola, la Puglia coi tesori di Egnazia, delle Isole Tremiti e di San Pietro in Bevagna e la Sicilia. Regione col maggior numero di location archeologiche subacquee e reperti, tra le isole Egadi, Pantelleria, l’area protetta di Plemmirio e Ustica col suo percorso di Punta Gavazzi e le Lezioni. Tra tutti, parchi, aree e siti sommersi più o meno organizzati per accogliere questa nuova forma di turismo.

Parco Sommerso di Baia, Lacus Ruspantini

Parco Sommerso di Baia – Lacus Naumacos

Parco Sommerso di Baia, Ninfeo, Vassallo
L’itinerario europeo continua in Grecia con Pavlopetri, città sommersa del Peloponneso, e Peristea alle isole Sporadi nel Parco Nazionale marino di Alonissos, primo museo sottomarino del paese. Di fronte ad Alessandria d’Egitto, ai resti della città di Heracleion (per i greci), Thonis (per gli egizi), dal VI a tutto il IV secolo A. C. polo del commercio fra il Mediterraneo e il Nilo, dall’archeologo Barry Cunliffe, dell’Università di Oxford, definita una scoperta travolgente. Per 1200 anni sepolta nella sabbia del fondale, forse a causa di un terremoto, oggi è visitabile anche attraverso la mappa interattiva dell’European Institute for Underwater Archeology. I primi reperti, trovati nel 2000 a trenta metri di profondità, includevano 64 relitti di navi, monete d’oro, stele giganti e la statua di Hapi, dio egizio della piena del Nilo, la più grande mai rinvenuta. Il viaggio continua in Israele, alla scoperta della città portuale Cesarea Marittima, fondata da Erode il Grande, tra il 25 e il 13 a.C, e in Turchia al sito di Kizlan a Mugla, dove la Dokuz Eylül University Marine Sciences e Technology Institute Faculty Member Assoc. stanno conducendo degli studi su un relitto di 24 metri con reperti di epoca ottomana. Non c’è mare o oceano che custodisca un patrimonio sommerso prezioso come quello del Mediterraneo, testimonial di un crocevia di commerci, civiltà, culture e arte durato millenni e unico al mondo, oggi oggetto d’interesse di un turismo particolare, che sembra avere grandi potenzialità. La condizione sine qua non, per i curiosi e chi studia o tutela queste ricchezze, è infatti avere un rapporto privilegiato con l’acqua e il mare, saper nuotare in immersione con le bombole o in superficie con maschera e boccaglio.
ULRIKE GUÉRIN
L’importanza di creare itinerari strutturati per il turismo subacqueo

Ulrike Guérin, Responsabile per UNESCO dell’Underwater Cultural Heritage Convention
“Una buona parte di territorio dedicato al turismo archeologico, interessa quello subacqueo”, dice Ulrike Guérin responsabile per UNESCO dell’ Underwater Cultural Heritage Convention, “in Italia molto importante. Oggi si è capito quanto il patrimonio culturale sommerso attiri le persone, salvaguardarlo e valorizzarlo però non è semplice. Ci sono le onde, la sabbia, i cambiamenti climatici, l’inquinamento e tutto ciò che va in mare dall’afflusso di gente sulle spiagge, quindi molto lavoro da fare. Bisogna aprirli ai visitatori con cautela, curarli, preservarli ed educare al loro rispetto, ma mai escludere la persone dalla loro conoscenza. Educazione e appello al buon senso sono basilari”.
Turismo e business da un lato e ambiente dall’altro, è possibile un bilanciamento tra le due cose?
Una gestione ragionevole è sempre una questione di bilanciamento, nello specifico, tra l’interesse del patrimonio e la sua preservazione. Non si tratta solo d’interesse turistico, in gioco c’è qualcosa che è parte di noi e della nostra cultura, per noi dell’Unesco, educare a tutto questo è fantastico. Molto però è lasciato all’abbandono, perciò è importante creare degli itinerari strutturati”.
Deve essere molto interessante il sito di Alessandria d’Egitto
Lì il problema è l’inquinamento, i rifiuti della città vanno in mare e tuffarcisi in mezzo non è ne piacevole ne pratico, in Mediterraneo ci sono molte cose da vedere, almeno 12 siti sono organizzati, in Italia, Baia è tra i più belli. Tra i nemici della cultura e dell’arte subacquea, Legambiente include i relittari, le archeomafie e, in Italia, una delle spese più basse d’Europa per la cultura, nonostante sia tra i paesi più ricchi al mondo su questo fronte.

La baia di Alessandria d’Egitto
BARBARA DAVIDDE
I tesori nascosti nel mare

Barbara Davidde, soprintendente nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo-foto Favignana
Archeologa e subacquea, membro dello STAB, il comitato tecnico scientifico dell’Unesco per la Convenzione del 2001 e soprintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Barbara Davidde, aggiunge: “l’erosione costiera, uno dei fattori che mette più a rischio le strutture sommerse o semi sommerse, molte delle quali vengono distrutte o danneggiate, poi i vandali e i furti.
Controllare e gestire penso sia molto difficile.
Si, bisogna essere strutturati in modo organizzato. La tecnologia aiuta, ormai un sito sommerso è gestibile benissimo, si tratta di investire e progettare.
Con che proventi finanziate queste cose?
Nei parchi non si può andare da soli, si paga un biglietto ai diving center accreditati che poi portano a fare la visita e questo vale anche per gli operatori del turismo che organizzano dei tour, una parte del pagamento del biglietto va al Parco. Le aree protette sono segnalate da boe, suddivise in zone A B etc, e hanno indicazioni su cosa si può fare nelle varie zone. Ai diportisti le capitanerie forniscono un regolamento su cosa si può o non si può fare e, per chi disattende, le multe sono salate.
C’è un’organizzazione che supervisiona tutte le realtà italiane?
Fatta eccezione della regione Sicilia che è autonoma, tutti i siti culturali sono sotto il controllo del Ministero della cultura. La Soprintendenza nazionale coordina e scheda il patrimonio subacqueo e si raccorda con le soprintendenze di archeologia, belle arti e paesaggio, i cui archeologi e subacquei collaborano col nostro ufficio.
Qual è il suo lavoro sott’acqua?
Dovendo fare progetti di ricerca, studio, valorizzazione e catalogazione del patrimonio, vado sott’acqua per studiare il reperto, per poi schedarlo e studiarlo etc. Soprattutto però, coordino équipes multidisciplinari per i progetti ideati da me che si andranno a realizzare. Il nostro è un lavoro multidisciplinare.

Barbara Davidde, Soprintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, in immersione

Barbara Davidde, Soprintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, al lavoro

Un incredibile patrimonio archeologico sommerso
A tutto questo si sommano siti e relitti sparsi per il mondo non sempre gestiti o gestiti male. Dalla XXIII Borsa Mediterranea del Turismo emerge che nei fondali di mari e oceani ci sono più di 202.000 relitti, di cui 15.641 in Mediterraneo, culla e al tempo stesso campo di battaglia, di civiltà e culture che hanno influenzato il mondo. Una mappatura del 50% di quelli italiani ha permesso di censire oltre 1.500 siti e relitti sommersi, alla cui tutela si stima dovrebbero andare €6,68 miliardi, per il 36% nel Mezzogiorno.
Inquinamento a parte, il patrimonio archeologico sommerso della Baia di Alessandria ha dell’incredibile. Uno dei porti più antichi al mondo e centro della cultura ellenistica, la città fu in gran parte distrutta o sommersa da terremoti e movimenti geologici. Circa 22.000 mq di un fondale pieno di relitti, reperti, statue, sfingi, le rovine del Faro e persino del palazzo di Cleopatra. Spostando il fuoco verso acque più lontane, negli abissi tra Spagna e Centro America è possibile trovare tesori Maya e Aztechi nascosti in galeoni spagnoli e portoghesi o ricchi carichi di navi pirata. Passando all’acqua dolce, inaugurato nel 2009 e protetto dall’UNESCO che lo ha definito la più antica stazione idrologica del mondo, il museo sommerso nel fiume Yangtze a Baiheliang, in Cina, visitabile dai vetri di due tunnel subacquei che partono dalla riva. Nelle sue acque si trova una trave in pietra di 1,6 Km, con più di 160 iscrizioni e 18 pesci Pietra, dagli antichi usati come standard idrico e i loro occhi come misuratori del livello dell’acqua.

La ricostruzione in 3D del faro di Alessandria
Crossing The Rubicon-Lanzarote – sculture di Jason de Caires Taylor

The Silent Evolution, MUSA, Messico, Jason de Caires
Musei e gallerie sottomarine dove l’arte vive e si trasforma
In linea con lo spirito toscano, pragmatico, chiaro, diretto e sempre attento alla “misura del mondo e dei rapporti, palesi e segreti, fra agli uomini e la natura” (Curzio Malaparte), il pescatore Paolo Fanciulli di Talamone ha pensato di contrastare la pesca illegale a strascico, creando La Casa dei Pesci. Un progetto nato nel 2012 concretizzatosi negli anni in un museo sottomarino di statue in marmo che, impedendo lo strascico delle reti, concede alla flora e la fauna marina di riprodursi in tranquillità. Le prime 20 statue sono scese in mare nel 2015 a Talamone, nel Parco Naturale della Maremma, e altre 19 a maggio 2020. Una sfida non facile, due anni solo per poter averi il permesso di inabissare le opere, ottenute scolpendo 100 blocchi di marmo di Carrara donati dallo scultore Franco Barattini. Oltre a lui, al progetto hanno aderito 39 artisti italiani e stranieri, tra cui Massimo Lippi, Giorgio Butini, l’inglese Emily Young, che hanno lavorato gratis. Per Catalani, un piccolo simbolo di territorio riconquistato alla natura, un modello unico al mondo che continua a crescere per la vita dell’economia e dei costumi delle popolazioni locali.

La Casa dei Pesci, Talamone, scultura The Weeping Guardian di Emily Young
Per i più famosi musei sommersi però bisogna andare lontano, il più esteso pare sia il MUSA (Museo Subacuàtico de Arte), tra Cancun, Isla Mujeres e Punta Nizuc, in Messico. Fondato nel 2009 da Jaime González Cano, direttore del National Marine Park, Roberto Díaz Abraham, al tempo presidente del Cancun Nautical Association, e dallo scultore inglese Jason de Caires Taylor, il pioniere del settore. Diviso nelle gallerie Salon Manchones, a 8mt di profondità, e Salon Nizuc a 4, accontenta i patiti del sub e dello snorkeling. Il primo museo di Jason de Caires Taylor e del mondo, però, è lo Underwater Sculpture Park di Moliniere Bay di Grenada, nei Caraibi. Più di 60 sculture, inclusa quella ormai famosa dei bambini che si tengono per mano in una sorta di girotondo intitolato Vicissitudes. Qui più che mai il mare arricchisce d’inedita bellezza le sculture, rendendole mutevoli e vive. Insieme all’utilizzo di materiali ecosostenibili e alla sensibilizzazione sulla salvaguardia dell’ecosistema marino, una prerogativa Jason, creatore di quasi tutti i principali musei sommersi.

Jason de Caires Taylor al lavoro su una sua scultura

Jason de Caires Taylor , Alberi e uomini della foresta del MUSAN a Cipro
Tra loro, l’Ocean Atlas, al largo di Nassau, nelle Bahamas, dove un’enorme ragazza inginocchiata, a 5mt di profondità, sorregge sulle spalle il peso dell’oceano. Parla ancora di lui il museo Atlantico di Lanzarote, alle Canarie, dove, a 15 mt di profondità, Jason celebra i migranti e i loro drammatici viaggi verso l’Europa, nelle opere Raft of Lampedusa e The Rubicon. Come altre, realizzate con un tipo di cemento Ph neutro, ecosostenibile e in grado di favorire lo sviluppo della vita marina. Al MOUA Museum of Underwater Art, nato per educare alla protezione della barriera corallina, colpisce la scultura Ocean Sireen che emerge dal mare, rivestita da LED collegati a sensori, la cui intensità e colorazione varia a seconda della temperatura dell’acqua.

The Raft of Lampedusa, Lanzarote, Jason de Caires Taylor

Ocean Atlas a Nassau Bahamas-ragazza che regge l’oceano di Jason de Caires Taylor

Donatella Zucca
Giornalista e scenografa