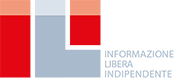MODA E MECENATISMO
Il lusso che ricostruisce la cultura
Dalle passerelle alle piazze storiche, i grandi brand del lusso investono nel patrimonio artistico come forma di identità e responsabilità. Dior, Ferragamo, Prada, Bulgari e molti altri finanziano restauri, musei, progetti culturali. Una nuova frontiera del mecenatismo privato che unisce estetica, territorio e strategia globale.
Donatella Zucca
Patrick Blanc, ideatore dei celebri muri verdi verticali, racconta come una sua opera realizzata sulla facciata di un edificio in una zona degradata di Parigi sia stata così apprezzata dai condomini da spingerli a prendersene cura personalmente. Un’osservazione che introduce un tema centrale e sempre più attuale: l’attenzione dei grandi marchi di diversi settori verso il patrimonio culturale, spesso sostenuto attraverso progetti di restauro e valorizzazione. Un interesse che rafforza l’identità e il valore del brand, espresso frequentemente sotto forma di mecenatismo o come strategia di marketing culturale. È il caso, ad esempio, del fondo da 10 milioni di dollari stanziato negli Stati Uniti da J. Paul Getty a sostegno di musei e organizzazioni no-profit operanti nel campo delle arti visive a Los Angeles, gestito dalla California Community Foundation, in risposta alla crisi post-Covid. Anche in Italia non mancano esempi significativi. La maison Ferragamo, da sempre legata al mondo dell’arte, ha avviato nel 2019 un accordo con il Comune di Firenze per il restauro di importanti gruppi scultorei. I grandi brand del lusso – termine che talvolta non rende giustizia alla loro vocazione all’eccellenza – contribuiscono a elevare la percezione del proprio valore investendo nella tutela del patrimonio storico-artistico, sostenendo progetti culturali e dimostrando una responsabilità attiva verso i territori in cui operano. In questo contesto è utile citare alcuni dati forniti da Artribune: in Italia il comparto dei beni di lusso conta circa 41.000 imprese e 372.000 posti di lavoro, pari al 40% dell’occupazione del settore a livello europeo. Un dato che conferma quanto questo mondo rappresenti una leva economica e culturale di primo piano. Un mondo, quello del lusso, dominato da figure che la giornalista e studiosa Annalisa Ercolani ha definito “più ricche dei monarchi, più influenti delle élite politiche e più riservate dei reali; non governano paesi, ma imperi commerciali costruiti attorno a una parola magica: lusso”.
Una definizione ampiamente condivisibile, alla quale si può aggiungere una seconda parola chiave: eccellenza.
Chi sono davvero i colossi capaci di influenzare i mercati globali, facendo “il buono e il cattivo tempo”?
Basta scorrere qualche cifra e analizzare i principali esempi per comprendere la portata e il peso che questi attori esercitano a livello mondiale. È il caso, ad esempio, di Dior – maison del gruppo LVMH – che, in collaborazione con la Venetian Heritage Foundation e la Marina Militare Italiana, ha promosso importanti interventi di restauro a Venezia: dalla Porta Magna dell’Arsenale al museo Ca’ d’Oro, dalla scalinata di Mauro Codussi alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista fino all’affresco Castigo dei serpenti del Tiepolo, alla Galleria dell’Accademia. Sempre LVMH ha affidato a Ma Group Ferroviaria il restauro di 18 carrozze di un treno storico degli anni Venti e Trenta, per una commessa da decine di milioni di euro. Anche altri grandi brand del lusso sono protagonisti di operazioni simili: Tod’s ha destinato 25 milioni di euro al restauro del Colosseo; Fendi ha sostenuto il recupero della Fontana di Trevi con una donazione superiore ai 2 milioni; Bulgari ha finanziato con 1,5 milioni il restauro della scalinata di Piazza di Spagna. Otb Group – che riunisce marchi come Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf – ha invece stanziato 5 milioni per il restauro del Ponte di Rialto. Nonostante il rallentamento della domanda nel settore del lusso, che ne ha ridimensionato temporaneamente la portata, spicca la figura di Bernard Arnault, fondatore, presidente e CEO di LVMH, nato nel 1949. Secondo le stime di Forbes, nel 2025 il suo patrimonio è valutato in 185,9 miliardi di dollari. LVMH controlla oltre 75 marchi iconici, tra cui Louis Vuitton, Dior, Fendi, Tiffany, Bulgari, Moët & Chandon. Al suo fianco, ma con un patrimonio significativamente inferiore, si colloca François Pinault, presidente e fondatore del gruppo Kering. Sempre secondo Forbes, fino al novembre 2022 figurava tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato di 36,4 miliardi di dollari, grazie a marchi come Gucci, Saint Laurent, Balenciaga e Bottega Veneta. Tuttavia, secondo il Bloomberg Billionaires Index, il suo patrimonio netto è crollato del 69% tra agosto 2021 e il 2025, scendendo a 18,6 miliardi di dollari: il calo più marcato tra i grandi player del periodo. Tra le grandi dinastie del lusso, non può mancare la famiglia Wertheimer, proprietaria di Chanel, uno dei più importanti marchi indipendenti al mondo, con un patrimonio stimato in circa 80 miliardi di dollari. I fratelli Alain e Gérard Wertheimer, oggi settantenni, sono comproprietari dell’azienda ereditata dal nonno Pierre, storico socio di Gabrielle “Coco” Chanel. Sempre secondo Bloomberg, il loro patrimonio combinato è stimato in 77 miliardi di dollari, ma ha subito una flessione del 14% nell’ultimo anno, complice il calo della domanda in Cina e le incertezze legate alla politica commerciale degli Stati Uniti. Grandi famiglie, imperi dinastici, personalità con potere diretto e indiretto capaci di muovere capitali e influenzare economie intere: in questo panorama, Bernard Arnault emerge senza alcun dubbio come figura dominante, in Europa e nel mondo. Naturalmente questi personaggi non sono i soli a distinguersi, altri uomini dotati di capacità imprenditoriali uniche, arricchiscono il contesto, per genialità, personalità, carisma, inventiva, capacità di segnare traguardi, favorire decisive virate, smuovere capitali. Per esempio, Giorgio Armani, fortemente legato al mondo dell’arte in ogni sua espressione, dal cinema alla progettazione di yacht, nelle calzature Diego della Valle, presidente del gruppo Tod’s, nella nautica Massimo Perotti, Presidente e Ceo dei cantieri Sanlorenzo, in prima linea in questi campi e non solo. Nei brand ricorrono Fendi, Dolce & Gabbana, Prada, Stefano Ricci, Tod’s, Otb Group e altri, in genere con forme d’investimento che, nonostante la crisi, continuano in modalità diverse e su fronti differenti da quelli pre-Covid o del primo post pandemia nel 2022.

The Italia Sea Group presenta il primo yacht progettato da Giorgio Armani.
Particolarmente attratti dai nuovi mercati sparsi tra i continenti, molti dei maggiori player già a febbraio hanno spostato investimenti e attenzioni al Zona Maco di Città del Messico, la più grande fiera d’arte dell’America Latina, in aprile a SP-Arte di San Paolo in Brasile al cui mercato dell’arte annovera una comunità coinvolta dalle sponsorizzazioni di Bottega Veneta e Chanel. A Tokyo in settembre sarà la volta della terza edizione del Tokyo Gendai e la Rakuten Fashion Week considerata la vetrina del fashion giapponese. l’Asia-Pacifico tornerà a novembre con le inaugurazioni, feste ed eventi di Shanghai Art Fair, Art021 e West Bund Art & Design. Una città aperta al mercato che ha dato filo da torcere ai gruppi del lusso nel post Covid 2021, richiusosi tra il 2023 e il 2024. A Shanghai il Bund è presidiato da tutti i grandi brand, Prada Group nella residenza Rong Zhai opera dal 2017 con esposizioni d’alto livello. Passi verso un futuro che ancora non si sa cosa ci regalerà di negativo o di positivo ma una cosa è certa, che al settore non mancano le forze, le potenzialità e le basi per poterlo affrontare con decisione e giusta resilienza. Per Dolce & Gabbana, Stefano Ricci, Salvatore Ferragamo, le Fondazioni di Cartier e Louis Vuitton e altri marchi top dell’alta moda, una missione che esprimono anche a partire dalle loro sedi, i loro prodotti e le proprie attività.
Stefano Ricci e il rinascimento della seta fiorentina
Telai in legno capaci di riprodurre un orditoio settecentesco ispirato a disegni di Leonardo da Vinci: è questo uno dei tesori custoditi dall’Antico Setificio Fiorentino, laboratorio fondato nel 1786 nel borgo fiorentino dell’Oltrarno, un tempo deposito per i telai delle nobili famiglie dei Gherardesca e dei Pucci. Acquisito da Stefano Ricci nel 2011, il setificio continua oggi a tessere magnifiche sete con gli stessi procedimenti artigianali del Rinascimento. Attraverso la divisione SR HOME Interior Design, Ricci ha portato questo patrimonio manifatturiero all’attenzione di una nuova élite internazionale, contribuendo a rilanciare lo stile e il saper fare italiano nel mondo. Sul fronte dell’arte e della cultura, si deve alla maison il restauro e la digitalizzazione degli antichi codici delle Corporazioni Fiorentine dell’Arte della Seta, della Lana e dei Linaioli. In occasione dei 40 anni del brand, celebrati nella Galleria degli Uffizi, Ricci ha finanziato la nuova illuminazione della Loggia dei Lanzi e successivamente del Ponte Vecchio, con un evento spettacolare aperto alla città. Per le celebrazioni dedicate a Leonardo da Vinci, ha sponsorizzato il trasferimento di preziosi disegni dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano agli Uffizi, restituendo al pubblico opere di straordinaria bellezza. Le collezioni della maison sono state ambientate in luoghi iconici come l’isola di Montecristo, la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, o in hotel di lusso all’interno di storici palazzi, contribuendo così a coniugare arte, moda e valorizzazione del patrimonio.
Fondazione Prada: da Ca’ Corner della Regina a Venezia a Milano, una città della cultura
Dal 1993, Fondazione Prada è attiva nei campi dell’architettura e del cinema, coinvolgendo artisti e creatori internazionali di primo piano. La sede veneziana, all’interno dello storico Palazzo Ca’ Corner della Regina, ospita mostre e attività legate a diverse discipline artistiche, diventando un punto di riferimento per la scena culturale lagunare.
A Milano, la Fondazione ha dato vita a una vera e propria città della cultura. Sorta all’interno di una ex distilleria dei primi del Novecento, la sede è stata ripensata dallo studio OMA sotto la direzione dell’architetto Rem Koolhaas, che ha saputo fondere magistralmente architettura industriale e contemporaneità, alternando spazi preesistenti a nuove strutture. Nel 2020, Fondazione Prada ha sostenuto la promozione della campagna ideata dall’artista Damien Hirst a favore di Save the Children, contribuendo alla raccolta di 3,3 milioni di euro per il programma.
Ferragamo, Fendi, Frescobaldi: architettura, arte e vino tra eredità e visione
Salvatore Ferragamo ha scelto come sede storica Palazzo Spini-Feroni, splendido esempio di architettura medievale fiorentina risalente al 1300, oggi sede anche del Museo Ferragamo, che racconta il legame della maison con il mondo dell’arte e della cultura. Il museo è membro dell’International Council of Museums.
L’impegno del brand nel sostenere il patrimonio artistico è concreto: già da anni Ferruccio Ferragamo ha donato 600.000 euro per il restauro di otto sale del terzo corridoio della Galleria degli Uffizi; nel 2017, tramite Art Bonus, ha devoluto 1,5 milioni di euro per il recupero della Fontana del Nettuno e, successivamente, oltre 1 milione per i gruppi scultorei di Piazza della Signoria.
A Roma, invece, Fendi ha eletto a proprio quartier generale l’iconico Palazzo della Civiltà Italiana, progettato nel 1937 in vista dell’Esposizione Universale del 1942 e poi divenuto museo della civiltà italiana. La trasformazione in sede operativa è stata affidata all’architetto Marco Costanzi, che ha firmato anche lo showroom milanese del brand. La sfida: riconvertire un grande spazio monumentale in un edificio funzionale e rappresentativo.
In Toscana, l’architettura del vino è diventata linguaggio d’identità per alcune delle famiglie più storiche della viticoltura italiana. Il network Wine Architecture include cantine progettate da firme come Renzo Piano, Mario Botta, Piero Sartogo, coniugando avanguardia estetica e tradizione agricola.
È il caso della tenuta di CastelGiocondo dei marchesi Frescobaldi, nota per il suo Brunello. Qui l’architettura interpreta la vocazione artistica della famiglia, radicata sin dal Rinascimento e oggi espressa da Tiziana Frescobaldi, presidente della Compagnia de’ Frescobaldi e ideatrice del progetto Artisti per Frescobaldi.

Artisti per Frescobaldi – Perbacco di Patrizio Di Massimo
Lo stesso spirito anima le cantine Antinori, una delle dinastie del vino più antiche al mondo: già nel 1385 Giovanni di Pietro Antinori era iscritto all’Arte dei Vinattieri. Le loro architetture d’autore e l’impegno per l’arte ne fanno oggi una realtà di riferimento internazionale.
Restando tra famiglie nobiliari, anche i Baroni Ricasoli – storicamente legati al Castello di Brolio – aderiscono al progetto Art of the Treasure Hunt, che porta l’arte contemporanea tra i filari del Chianti Classico.
In Maremma, infine, la tenuta Rocca di Frassinello, nata da una joint venture italo-francese, ospita la Barricaia progettata da Renzo Piano, oggi considerata un capolavoro architettonico e simbolo dell’incontro tra vino, design e cultura.

Cantina Antinori Chianti Classico, progettata da Marco Casamonti, fondatore di Archea Associati.

Antinori Art Project – Biosfere di Tomas Saraceno – Copy Armellin Filippo
Moda, arte e mecenatismo: quando il lusso investe nella cultura
Per Dolce & Gabbana, le collezioni diventano veri e propri omaggi agli artisti e agli artigiani italiani di ogni epoca. Da anni, la maison promuove la riscoperta della manualità e della tradizione attraverso le sue Botteghe di Mestiere, dove forma giovani artigiani, e con l’impiego di giovanissimi ricamatori negli Atelier di Milano. Accanto a loro si collocano realtà altrettanto impegnate: Gucci ha destinato 2 milioni di euro alla valorizzazione botanica dei Giardini di Boboli; la Fondazione OTB dello stilista Renzo Rosso ha finanziato con 5 milioni di euro il restauro del Ponte di Rialto a Venezia e molte altre iniziative. Dal 2013 al 2016, Bulgari ha donato 3 milioni di euro per il restauro della Scalinata di Trinità dei Monti a Roma, contribuendo anche al recupero di un mosaico alle Terme di Caracalla e all’area sacra di Largo Argentina, oggi riaperta al pubblico proprio grazie all’intervento della maison. Anche la Francia mostra un impegno solido: da Coco Chanel, cultrice dell’arte, il brand ha ereditato una visione di continuità, testimoniata dall’investimento di 25 milioni di euro per il restauro del Grand Palais a Parigi. I gruppi LVMH e Kering sono stati tra i primi a intervenire dopo l’incendio di Notre-Dame de Paris, stanziando centinaia di milioni per il restauro. Bernard Arnault, CEO di LVMH, ha donato 200 milioni di euro, mentre François Pinault, patron di Kering, ne ha destinati 100 milioni, rinunciando persino ai benefici fiscali. Il legame tra moda e patrimonio culturale è profondo e articolato: coinvolge ogni ambito dell’eccellenza, dalla gioielleria alla pelletteria, dagli occhiali alla cosmesi, fino all’industria nautica e al settore vinicolo. Le collaborazioni con istituzioni, le collezioni ispirate a opere d’arte, l’uso di location culturali diventano strumenti distintivi. La gioielleria, in particolare, è da sempre legata all’artigianato e all’arte: spesso, essa stessa è considerata un bene culturale. Qui emergono collaborazioni con musei, creazioni ispirate a reperti storici e tecniche tradizionali che riportano al centro il valore del “saper fare”. Anche il mondo dell’eyewear si distingue: EssilorLuxottica ha lanciato durante la pandemia il progetto “Eyes on Art”, volto a rendere l’arte più accessibile attraverso il digitale, in collaborazione con musei e istituzioni culturali. Il settore vinicolo, in Italia e in Francia, ha da sempre un’anima culturale: lo si vede nelle wineries della Napa Valley in California, e persino nella St. Catherine’s Valley, tra le Cascate del Niagara e il lago Ontario in Canada, dove da oltre 70 anni vino e arte si incontrano. Nella nautica, i cantieri Sanlorenzo collaborano con Art Basel dal 2018, mentre dal 2021 supportano la Sanlorenzo Arts, piattaforma dedicata all’arte contemporanea. The Italian Sea Group ha firmato l’Artexplorer, catamarano a vela di 47 metri, primo museo-galleria d’arte navigante, e due yacht da 72 metri sviluppati insieme a Giorgio Armani. Non manca l’orologeria, da sempre attenta a fondere arte e tecnica: emblematico il caso del Reverso di Jaeger-LeCoultre, su cui vengono riprodotte in miniatura opere di Claude Monet e altri grandi maestri.

Sanlorenzo Art Basel – Basilea – Opera di Yves Klein
Ma qual è il risvolto della medaglia?
Se da un lato, in tempi di difficoltà economica per i Comuni e per il Ministero della Cultura, l’intervento dei privati appare come una risorsa preziosa e necessaria, dall’altro c’è chi solleva dubbi e perplessità. C’è chi considera questo mecenatismo una forma di mercificazione della cultura, una sostituzione inaccettabile dei finanziamenti pubblici, e chi parla di un vero e proprio “cavallo di Troia”, per introdurre visioni elitarie e poco democratiche della fruizione culturale. Che dire allora? Forse la risposta migliore sta in un invito di Vincent Van Gogh, quanto mai attuale: “Se senti una voce dentro di te dire che non puoi dipingere, dipingi con tutti i mezzi, e quella voce sarà messa a tacere.”
“Non governano paesi, ma imperi commerciali costruiti attorno a una parola magica: lusso”

Donatella Zucca
Giornalista e scenografa